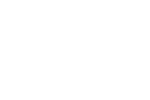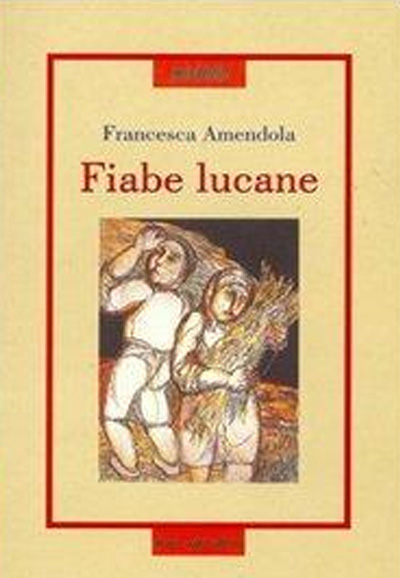Laurenziana 17 ottobre 1929 – Roma 8 marzo 1996

Nato a Laurenzana nel 1929, Michele Parrella si trasferì giovane a Roma, dove visse in maniera picaresca e originale nel pieno della stagione americana e felliniana. Aduggiava certamente allo svarione folclorico per i suoi cappelli stravaganti e la sua aria trasandata. Si accompagnava a un gruppo di poeti di provincia come Tito Balestra e Vito Riviello, frequentava la galleria Dell’Arco di Peppino Appella in via Mario dei Fiori e il mondo della sinistra comunista, Trombadori e Alicata per esempio, ma anche quell’intellettuale lucano di grande qualità filologica come don Giuseppe De Luca presso le cui edizioni di Storia e Letteratura nel 58 pubblicò i versi di Paisano. Intanto non perdeva i rapporti con riviste importanti di letteratura, da “Civiltà delle Macchine” del suo conterraneo Sinisgalli a “Nuovi Argomenti” e “Nord e Sud”. Parrella era uno dei tanti meridionali approdati nella città eterna ai primi anni cinquanta e cercava fortuna al modo in cui l’avrebbe cercata più tardi Riviello, nel momento in cui chiudeva la Nuova Libreria di via Pretoria per trovare una strada nell’editoria di poesia.
Parrella ha scritto versi introvabili fino agli anni ottanta, quando Appella gli pubblica La piramide di pietrisco con le edizioni della Cometa. Ma bisognerà attendere il 1994 perché La piazza degli uomini trovi asilo presso la Marsilio e dunque avrà una maggiore distribuzione. Ancora a fine millennio i suoi libri erano introvabili. Finché Giuseppe Lupo e Andrea Di Consoli non si presero la briga di ripubblicare con la Nuova Avagliano tutte le Poesie che Michele Parrella aveva composto tra il 1947 e il 1996, anno della sua morte. Cinquant’anni di scrittura, un canzoniere di circa duecento componimenti. Come dire quattro poesie all’anno.
Con Parrella il panorama poetico della Basilicata si fa completo. A Sinisgalli, Scotellaro, Pierro, Stolfi, Giagni, Trufelli si aggiunge un tassello importante.
Debbo dire che questo gruppo di poeti, pure nelle differenze evidenti di esperienze e di temi sembra tutto riconducibile a un’unica voce, come a una scuola o a un gruppo i cui esponenti si siano tra loro contagiati, si siano infebbrati e innamorati a vicenda. E’ certamente il sottofondo antropologico e geografico al quale fanno riferimento a chiuderli tutti in una stessa sonorità, a una dialettalità colloquiale fondata sull’amarezza, sul fiato della morte, sulla luttuosità, sul disagio collettivo, sulla presenza del destino e sul bisogno di combattere contro lo Stato, contro la Sorte, contro Dio e contro gli Uomini. I cantori della terra del rimorso e del ritardo, della drammaticità e del dolore. I poeti del realismo magico lucano.
Quando si allontanano dalla Lucania, questi poeti seguono ognuno la propria strada e si allontanano dalla fonte ispirativa e parlano d’altro. Sinisgalli di religiosità delle macchine, Giagni di malattie della borghesia metropolitana, Parrella di occasioni quotidiane.
C’è dunque un Parrella dei primi anni, l’amico di Scotellaro, il poeta che si ritrova nel telero di Italia 61 dipinto da Levi e oggi a Matera presso palazzo Lanfranchi. Parrella vi recita la parte del giovane in cerca di verità, tra Nitti, Dorso, Fortunato, Mazzarone e Zanardelli. Ma è il Parrella angosciato da una cultura arcaica che pesa sull’animo dei giovani come una croce. Le poesie di questi anni sono dominati dalla ferocia del cupo cupo,lo strumento contadino che rimbomba come un tuono, come un tamburo o un cuore materno e forse meglio accompagna i militari alla battaglia. Ma qui accompagna gli uomini alla battaglia della vita, scandita attraverso feste di nascita, battesimo, matrimonio, attraverso ricorrenze che richiamano sempre la ferocia del destino, incalzante sugli uomini, pronto a distruggere. Il mondo descritto da Parrella è sgarrupato e moribondo, ha a che fare coi ponti di San Giacomo, cioè i luoghi di trapasso per l’aldilà, ha a che fare con pizziche e tarantismi, dunque con la psicologia malata, con le mamme nere nei panni neri e nei cieli neri. I suoni allucinati ed espressionisti dei tamburi che accompagnano le processioni, i funerali, le feste. Tutto uguale, tutto con lo stesso ritmo. Un ritmo che nella memoria di Parrella si fa più melodioso grazie alla poesia popolare dalla quale egli prende a piene mani. Una ritmica che si sposa alla sentenziosità di Orazio e alla malinconia di Quasimodo, ma il cui sottofondo sta nella tradizione lucana del Novecento, nella scoperta che Sinisgalli ha fatto del linguaggio colloquiale e quotidiano contro una poesia che giungeva dall’800 con troppa aulicità e altisonanza verbale.
Poi Parrella parte per Roma, la sua poesia cambia quasi del tutto, nel momento in cui egli acquisisce nuove amicizie ed entra nel mondo di coloro che contano nelle patrie lettere. Una poesia più encomiastica, che si allontana da quell’unisono di cui ho detto. Facendo il verso a Scotellaro scrive “Ho perduto l’innocenza operaia”, laddove gli innocenti scotellariani erano i contadini. L’Italia mutava e Parrella sentiva il bisogno di produrre una poesia della cronaca, un radiogiornale in versi dove si parlava dell’emigrazione contadina, della nascita di Mirafiori, della disoccupazione e lo svuotamento dei paesi “i vivi se ne vanno/restano i ritratti e il cesto delle mele/a guardia della casa”. Così il linguaggio, finora assolutamente antiermetico, come nella cultura degli anni 50 dominata dall’esperienza di Accrocca e di Portonaccio, si fa progressivamente più cifrato e la cantabilità si scioglie. Ora i suoi amici sono Candice Bergen, Togliatti e Veruska. I temi sono il partito armato, i comizi di Trombadori, una festa in casa Guttuso o della Marzotto. Una sequenza di fatti e di misfatti che conosce l’Italia della prima e della seconda repubblica e che Parrella chiosa puntualmente, come costruisse un diario in pubblico. Sempre più lontano dai suoi paesi e con ritmi nuovi, linguaggi industriali e moderni, che si accostano alla poesia prosastica di Pasolini e perdono col vocabolario materno anche l’incisività del maledettismo lucano.
https://www.francescomastrorizzi.it › blog › michele-parrella
BLOG
Michele Parrella, cantore del Novecento
9 Luglio 2019
Nell’Olimpo della poesia lucana del Novecento, accanto a nomi come Rocco Scotellaro e Leonardo Sinisgalli, non può mancare di essere inserito Michele Parrella, poeta bohémien con la Basilicata nel cuore, che vediamo ritratto in mezzo ai braccianti agricoli, proprio insieme al “poeta contadino” Scotellaro, nel grande dipinto “Lucania ’61” di Carlo Levi, realizzato a Torino in occasione del centenario dell’Unità d’Italia e oggi custodito a Palazzo Lanfranchi di Matera, a testimoniare la vicinanza dei due cantori al popolo lucano.
Michele Parrella nacque a Laurenzana, piccolo centro a quaranta chilometri da Potenza, il 17 ottobre 1929. Più giovane di sei anni del “collega” Scotellaro, apparteneva ad una famiglia borghese. Suo padre, infatti, esercitava la professione di medico condotto a Potenza, città dove Michele frequentò il Ginnasio e il Liceo. La perdita prematura della madre, per malattia, e del padre, morto suicida subito dopo, lo costrinsero a interrompere gli studi universitari di medicina a Siena. Si trasferì, quindi, a Roma, presso il fratello, che provvide al suo sostentamento. Erano i primi anni ‘50, che lo videro impegnato in collaborazioni con alcune riviste e giornali e in una felice attività di documentarista.
Visse in perpetuo viaggio tra Roma, la Basilicata, il Nord Italia, la Svizzera e la Germania. Entrò a far parte del mondo intellettuale e artistico della Capitale, quello della “dolce vita” felliniana e di “via Margutta”, e della “intellighenzia” di sinistra. Assiduo frequentatore dei salotti culturali, intrattenne solide amicizie con personaggi illustri della letteratura, dell’arte, del cinema e della politica, come Carlo Levi, Renato Guttuso, Antonello Trombadori, Leonardo Sinisgalli, Giovanni Russo, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi, Enrico Berlinguer e tanti altri. Condusse vita da eterno scapolo, intrecciando avventure sentimentali con donne del gran mondo. Quando, però, quel mondo si dissolse, a Parrella non rimase che una vita povera e malatissima. Morì a Roma, non già vecchio, l’8 marzo 1996.
La figura di Michele Parrella era quella tipica dell’artista mondano, del viveur giramondo e stravagante, sempre con il panama sulla testa e il sigaro spento in bocca, alla continua ricerca di stimoli non solo intellettuali, mai appagato della “grande bellezza”. I suoi atteggiamenti volutamente eccentrici, fintamente allegri, erano un modo per allontanarsi dai problemi esistenziali e dalle noie della quotidianità, del vivere ordinario, che rifuggiva con forza. Il sentimento della solitudine fu sempre incombente nella sua vita e ad esso associò il bisogno di affetto, di amicizia, di riconoscimento e considerazione.
Era poco attento alla pubblicazione delle sue poesie, che spesso venivano improvvisate e donate al momento agli amici. Molte sono state recuperate e raccolte nel 2007 nella pubblicazione “Michele Parrella. Poesie (1947-1996)”, a cura di Giuseppe Lupo. Molte altre si suppone siano ancora in giro, disperse tra carte e cassetti. Le raccolte ufficiali, pubblicate in vita, non sono molte: “Poesia e pietra di Lucania” (1954), “Paisano” (1958), “La piramide di pietrisco” (1975), “La montagna di tufo” (1975) e “La piazza degli uomini” (1994).
Tutta la sua produzione poetica è costellata di dolenti richiami e di struggenti echi d’amore alle proprie radici, alla terra natia di Lucania, alle problematiche del mondo contadino meridionale, talora capaci di assurgere a questioni universali. Nei suoi versi entrano motti, canti, cantilene, filastrocche, orecchiati da ragazzo nel suo paese. La Lucania che Parrella conosce, e che vede da Roma o nei suoi frequenti viaggi di ritorno, è la “Lucania persa” (come il titolo di una lirica dedicata a Scotellaro), segnata dallo spopolamento.
Sorprende nelle sue poesie la vicinanza di diverse modalità di composizione e di variegati contenuti. Parrella si muove attraverso una grande varietà di generi, al punto da rendere impossibile qualunque collocazione o catalogazione. La sua poesia è segnata da diverse fasi. Inizialmente, negli anni giovanili, racconta il suo paese natio con un ricco repertorio di gesti, riti, liturgie, azioni del mondo popolare e contadino, da cui si sente irresistibilmente attratto.
Nella seconda fase poetica viene avvinto dal disincanto e dall’amarezza nell’affrontare il tema dell’emigrazione, che affligge una Lucania in cui la speranza è di là da venire e la civiltà una lontana promessa. Dopo la pubblicazione nel 1954 della sua raccolta “Poesia e pietra di Lucania”, seguita di pochi mesi alla morte prematura di Rocco Scotellaro (15 dicembre 1953), alcune sue poesie sono pubblicate da Leonardo Sinisgalli su “Civiltà delle Macchine”, di cui è già collaboratore e lo rimarrà a lungo, come testimonianza di una voce coraggiosa nella denuncia dello scacco del Meridione. I Sassi di Matera, abbandonati e ridotti senza un’anima tra gli anni ‘60 e ‘70, rappresentano il simbolo della fuga e dello spopolamento del Sud.
La terza fase della sua poesia risente del soggiorno romano e ci offre l’immagine del poeta-cronista che assiste ai cambiamenti di vita e di pensiero che, nella seconda metà del Novecento, mutano rapidamente il corso della storia mondiale. Non mancano, però, tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, gli slanci nostalgici e pieni di sentimento per Laurenzana e la Basilicata. Infatti, pur attento alle vicende più grandi del mondo, non sfugge al desiderio di ricucire con la propria terra natale lo strappo consumato al momento della sua partenza. Così, tutte le volte che se ne presenta l’occasione, egli torna a Laurenzana e in più di qualche circostanza soggiorna a Matera, servendosene come base per raggiungere altri luoghi della regione. Di questo suo girovagare restano poesie che i ricordi dell’infanzia trasformano in commosse elegie, in cui compaiono, mitizzati, luoghi della Basilicata come il “fiume della Serra” (Serrapòtamo), il monte Caperrino, la Taverna d’Anzi, il Volturino, il Monte Saraceno, la Sellata, il Pierfaone.
MICHELE PARRELLA, PRINCIPE DEL SERRAPOTAMO DI LUCIO TUFANO IL 03/11/2020

LUCIO TUFANO
il cuore del poeta
«Questa parola serve per moti e desideri d’ogni genere, ma ciò che è costante è che il cuore – negato o rifiutato che sia – vuole essere un oggetto di dono.
Così com’è sentito, fissato, nella sfera dell’Immaginario, il cuore è l’organo del desiderio (che si gonfia, si spezza, si stringe, si comprime, si indurisce e si ammoscia …), come il sesso. Che cosa farà il mondo, che cosa farà l’altro del mio desiderio? Questa è l’inquietudine nella quale si ritrovano tutti i moti del cuore, tutti i ‘problemi’ del cuore».
Roland Barthes
Pur non ignorando le importanti esperienze letterarie verificatesi negli anni Trenta, ricche di significati per la ricerca linguistica e di scoperte all’interno della civiltà, della società e dei suoi problemi, nel secondo dopoguerra la letteratura meridionale si inseriva nella storia del neorealismo caratterizzandosi come la parte più neoverista e neonaturalista, raccogliendo le diverse eredità e rivelando non poche ambizioni di quel clima: l’elegia meridionale, la nuova centralità della questione politica e culturale. Si verificò una strana osmosi tra esigenze ideologiche di tipo populista ed educazione letteraria gestita anche in chiave “decadentista”.
Si distinsero le sensibilità più autentiche, ricche di estro, di senso critico ed autocritico nei confronti delle ideologie e dei luoghi comuni. Di lì scaturì una schiera di scotellariani minori … leviani, postscotellariani e postleviani … il declino del neorealismo, non esaurì le tensioni e quella carica ideale che hanno ancora per anni successivamente animato e tenuto vivo lo spirito della protesta.
Riflessione e letture di quella produzione poi, indagini e studi hanno al fine stabilito un più stretto rapporto tra letteratura e Basilicata come territorio, tradizioni, metafore, condizione urbana e di sviluppo, documenti di vita.
Michele Parrella che assieme a Scotellaro fu uno dei veri dioscuri di Carlo Levi nella premessa alla sua prima breve raccolta di versi “Poesia e pietra di Lucania” scriveva: “La società del Sud, quella che si è venuta caratterizzando attraverso la letteratura come mondo meridionale, mi appare profondamente in subbuglio, in movimento. La Lucania è una parte di questa società, ne riproduce le essenziali strutture …” poesia giovane ma terribilmente seria e dolorosa, scrive poi Giuseppe Sibilla – sui venticinque anni di Parrella, sembra gravare il peso di una condizione sociale ed umana che si trascina da secoli … “Un dolore antico e inesorabile, se non contenesse come molla potente il senso della ribellione, la partecipazione aspra e aperta contro il lurido seme della retorica, nella lirica “La Patria”. Proprio quando Togliatti sentenziava che i poeti non potessero essere “cicale” ma formiche e Vittorini ribatteva come non dovessero neppure suonare il piffero della rivoluzione, visto poi come delle rivoluzioni approfittino sempre i tiranni per insediare il loro fascismo, fatto di strutture, codazzi, egotismi ed ingordigie.
Ma chi sono questi poeti? Segnalatori di quanto sarà la immane perdita della natura? Chi sono i poeti?
I poeti sono strani tipi che vivono di una penna o non vivono affatto; sono strani tipi che fendono la nebbia a passi d’uccello e sotto ali di canzoni e come la gente – la massa – feticcio inguaribile del nostro tempo, li vede «creature singhiozzanti e malinconiche».
E questi furono i “prodigio”, i direttori d’orchestra che sanno dirigere prima di essere nati alla fatica delle crome e delle biscrome. Questi tesserono le poetiche del demiurgo per una reminiscenza dell’infanzia regionale lucana, il passaggio attraverso la galassia contadina. Nostalgia positiva, laddove non fu nostalgia negativa, ispirata a motivi di reazione o restaurazione, bensì a qualcosa che ci è ormai sfuggita, monito per noi che perdemmo il paese “la nave che vuole partire”, l’universo paesano, il ritratto di esso e del suo tempo.
«Paisano», la raccolta del 1957, è quindi la coscienza che ci portiamo dentro, è una ripresa … con gli occhi dell’oggi e con il “noi” del gruppo, del vicinato, dei fratelli, degli amici, di tutti coloro cui sta a cuore la liberazione di ogni cosa. «La montagna di Tufo» e la «Piramide di Pietrisco» sono l’ironia e la meridionalità, il riconoscimento di tutti non come omologazione, ma come identità.
Quell’odore di legno pregiato, quel rame, quell’autentica memoria del vino, quei metalli, quel sentore antiquario degli oggetti: cose, sentimenti, angoli, scorci che meritano di diventare tutti beni culturali: luoghi e simboli racchiusi nello scrignetto azzurro di «Paisano».
Se al poeta del mito civile, autore di poesie di gesta e di oltremare, se al poeta-soldato fu dato il titolo di Principe di Montenevoso per aver cantato la gioia del mondo ed essere rinato ogni mattina, per aver sfidato i nembi ed i fati, sovvertito le comuni leggi del vivere ed essersi proclamato re di tempeste e di uomini, aver teso alla conquista del cielo, invocato Icaro e la morte illustre, essersi rifugiato nel focolare domestico, aver osservato i pastori che pel tratturo scendono al mare, contemplato l’ulivo e la spiga, la pioggia nel pineto ed il novilunio, si erge il Vittoriale sulle sponde del Garda, ci appare quasi giusto – e perché no – che per il poeta di Lucania, che ha raccontato le storie del guardiese e del sagrestano perdiluna, che ha segnato i più larghi confini della Patria ed ha visto come la pioggia cada sulla pelle dell’asino e la piena raduni i vivi ed i morti, il cupo cupo sia più triste del tuono, i monti lucani cadano in pezzi, le stradine siano appese agli orti, e le facce navighino nei bicchieri tra i berci delle osterie, che si erga lo “Sconfittoriale” sulle sponde del Camastra. Si tratta di un nostro poeta che ci parla ancora della pupattola di fichi e della collana di sorbe, delle querce spaccate dal fulmine e che ha visto cadere nei letti vuoti del sole i galli, i fanciulli, il tuffo stridulo del falco e ci racconta come una foglia si sia attorcigliata alla candela.
È giusto che lo si onori anche del titolo di “Principe di Serrapotamo”. Ecco che la Basilicata, con esperienze diverse, legate alle zone ed alle varie formazioni, una pluralità di voci registrate a seconda delle condizioni di cultura assimilata – assume le dimensioni di un ampio ed articolato mosaico, i cui tasselli appartengono alle voci poetiche, o alle origini: Sinisgalli come presenza storica della Val d’Agri (Montemurro), Michele Parrella per le contrade della Camastra (Laurenzana), Scotellaro e Levi, presenze che influenzano il Tricaricese ed il Materano, Riviello per la città di Potenza tra l’Ottocento ed il Novecento.
Vi è una strategia finale propria del poeta, dopo i mille tentativi di rivolta, dopo aver issato i folgoranti stendardi del lirismo ideologico, dopo aver sostato nelle piazze in fermento, dopo aver pianto ed invitato a piangere su l’Unità per la morte del grande oppositore Palmiro Togliatti, dopo gli inni a Satana, quella dello ostentato compiacimento della Sconfitta, umile oggetto travolto dal torrente dell’arroganza, nonostante la precisa coscienza di essere di più. Una strategia dell’autodistruzione come estremo tentativo di libertà, una teoria della “minima resistenza al potere”, che appare alla “lucidità” l’apparente “stupidità” del proprio comportamento, alla volontà di potenza ed alla organizzazione generale del potere il balbettìo sommesso dell’impotenza dichiarata, alla macchinosità, alle sofisticate linee, alle stringate logiche, alle conclusive e poco comprensibili mediazioni, lottizzazioni … il semplice chiacchierare. E Michele – negli ultimi anni – non fece che chiacchierare, chiacchierava per ore, disperato ed ironico, comico nel senso kafkiano, ma sempre altamente poetico.
Ed il vagabondare di Michele fu, fin dalla notte dei tempi, una caratteristica della fabulazione, affine al “vagare” di tanti altri poeti, rimanendo fuori dalle logiche contingenti. E approdava sulle aride coste della provincia di origine con il suo rifiuto del “moderno”, il suo cappello di paglia a falde larghe, il foulard, l’abito panamense ed antiquato, il mantello, le scarpe bianche, il bastone ed il sigaro, i capelli allungati sul collo e … gli occhi chiari di azzurro e di innocenza … e non vi furono Penelopi a disfare le loro tele, ma solo il numeroso esercito di boriosi Proci, i Proci della poesia che, acquattati da ogni parte, gli contendevano l’aria da respirare e gli contendono ancora il primato della poesia.
Perciò lo “Sconfittoriale”: perché il poeta nacque sconfitto, come tanti, perché la Lucania registrò la sconfitta del Mezzogiorno e perché – come dice Baudelaire – il poeta ha ali immense che gli impediscono di camminare. Il poeta un “pitocco non è già”, per un pubblico che non c’è